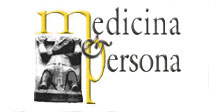Morti di parto e sistema sanitario: dalla volontà buona una responsabilità vissuta
I recenti e dolorosi fatti di cronaca sulle morti al parto, hanno suscitato commenti sui media che hanno affrontato in vario modo quanto accaduto. In molti casi, ad onore del vero, hanno permesso ai loro estensori e, speriamo, anche ai lettori, di fare delle opportune e sempre valide riflessioni sul significato del vivere e sulla non eccezionalità del morire nella vita umana. Questo nel mondo post moderno dove si tenta di esorcizzare ogni morte riducendola a conseguenza di colpa/errore di qualcuno, solo perché non essendo più abituati a chiedersi chi è l’uomo, da dove viene e dove va, (domande che da millenni caratterizzano la “differenza” umana), non si sa più stare di fronte al fenomeno uomo con le sue grandezze e i suoi limiti.
In altri articoli è invece stata posta a tema la responsabilità del medico e degli altri operatori sanitari. Michela Marzano il 13 gennaio su Repubblica, dice: “Quando si arriva in Ospedale o si consulta un medico, lo si fa per essere aiutati. Ci si affida e ci si fida. Abbandonandosi alla buona volontà di chi, quella fiducia, dovrebbe fare di tutto per rispettarla e non tradirla. […]. È questo il compito del personale sanitario, ed è questo che ogni donna incinta ha il diritto di aspettarsi quando arriva in Ospedale.”1 Sorge una domanda: oggi è sufficiente la buona volontà per fare bene il mestiere di medico? Certo occorre innanzitutto una volontà “buona”, cioè quella posizione per cui chi svolge il mestiere di medico (o di altro operatore della salute), sceglie di lasciarsi innanzitutto interpellare personalmente e drammaticamente dall’altro uomo che gli si presenta con un bisogno e decide (e deve farlo non una volta per tutte ma ogni volta!) di cercare di rispondergli, di farsi carico fino in fondo dell’uomo che lo interpella. Si chiama responsabilità (da rispondere) ed è umana prima che professionale. Un affidarsi meccanico alle regole (le linee guida) o il sempre più diffuso ritrarsi di giovani e meno giovani sono un segno del tentativo di estraniarsi anche psicologicamente dal peso delle situazioni in cui ci si trova ad operare. ”C’è un livello, invisibile agli occhi altrui, della professione medica che ha a che fare con la coscienza personale del medico come uomo, come soggetto che costruisce la propria identità personale, come colui che, al pari di ogni suo simile, si guarda ogni mattino allo specchio e fa un bilancio del proprio esistere. Il fatto di agire sul corpo altrui non lo sottrae alla sua diretta responsabilità umana”.2 Perciò non una “buona volontà” generica è richiesta ma è in questione la responsabilità. È questa capacità di “rispondere a” che si sta smarrendo nel mondo sanitario. Tenerla viva richiede un lavoro educativo che è difficile fare da soli. L’Associazione Medicina e Persona, che ha come scopo principale di custodire il legame tra la Medicina e la Persona, in questi anni ci ha indicato la via del lavoro in sanità: per prendersi cura della persona col suo bisogno di salute nella sua integralità, cioè per essere responsabili del nostro paziente, occorre in primis guardarlo, incontrarlo, ascoltarlo, prenderlo in considerazione per quello che è a partire dalla sua storia clinica (si pensi ad anamnesi ed esame obiettivo così maltrattati!!). Questa posizione non è un optional ma ha un’innegabile utilità tecnico-professionale. Il Prof. Mahfoud nel 2010 ci ricordava che: “…la responsabilità emerge proprio da questa interazione, dalla presenza che uno è per l’altro in un incontro reale. Se manca la propria presa di posizione esistenziale, si amministrano processi, si coordinano riunioni, si esaminano dinamiche […]3ma, non si cura l’uomo reale.” Per tornare ai fatti di cronaca, occorre essere consapevoli che oggi la conoscenza si acquisisce insieme, nasce come competenza condivisa. Il lavoro d’équipe di cui tutti riconoscono la necessità non è per dividere, stemperandola, una responsabilità, ma per costruire umilmente percorsi nella complessità. Questi guidano, nelle situazioni specifiche, la responsabilità degli operatori che rimane drammaticamente dei singoli. Infine, come le indagini in corso sembrano suggerire, la responsabilità dell’operatore oggi non può non arrivare all’aspetto organizzativo, inteso come modo di lavorare al meglio; infatti se i professionisti non si assumono questo compito se lo assumeranno altri che non ne conoscono i termini reali. Offriamo questo contributo come spunto di riflessione e dialogo a tutti i nostri Colleghi desiderosi di collaborare al miglioramento dei luoghi della cura.
In altri articoli è invece stata posta a tema la responsabilità del medico e degli altri operatori sanitari. Michela Marzano il 13 gennaio su Repubblica, dice: “Quando si arriva in Ospedale o si consulta un medico, lo si fa per essere aiutati. Ci si affida e ci si fida. Abbandonandosi alla buona volontà di chi, quella fiducia, dovrebbe fare di tutto per rispettarla e non tradirla. […]. È questo il compito del personale sanitario, ed è questo che ogni donna incinta ha il diritto di aspettarsi quando arriva in Ospedale.”1 Sorge una domanda: oggi è sufficiente la buona volontà per fare bene il mestiere di medico? Certo occorre innanzitutto una volontà “buona”, cioè quella posizione per cui chi svolge il mestiere di medico (o di altro operatore della salute), sceglie di lasciarsi innanzitutto interpellare personalmente e drammaticamente dall’altro uomo che gli si presenta con un bisogno e decide (e deve farlo non una volta per tutte ma ogni volta!) di cercare di rispondergli, di farsi carico fino in fondo dell’uomo che lo interpella. Si chiama responsabilità (da rispondere) ed è umana prima che professionale. Un affidarsi meccanico alle regole (le linee guida) o il sempre più diffuso ritrarsi di giovani e meno giovani sono un segno del tentativo di estraniarsi anche psicologicamente dal peso delle situazioni in cui ci si trova ad operare. ”C’è un livello, invisibile agli occhi altrui, della professione medica che ha a che fare con la coscienza personale del medico come uomo, come soggetto che costruisce la propria identità personale, come colui che, al pari di ogni suo simile, si guarda ogni mattino allo specchio e fa un bilancio del proprio esistere. Il fatto di agire sul corpo altrui non lo sottrae alla sua diretta responsabilità umana”.2 Perciò non una “buona volontà” generica è richiesta ma è in questione la responsabilità. È questa capacità di “rispondere a” che si sta smarrendo nel mondo sanitario. Tenerla viva richiede un lavoro educativo che è difficile fare da soli. L’Associazione Medicina e Persona, che ha come scopo principale di custodire il legame tra la Medicina e la Persona, in questi anni ci ha indicato la via del lavoro in sanità: per prendersi cura della persona col suo bisogno di salute nella sua integralità, cioè per essere responsabili del nostro paziente, occorre in primis guardarlo, incontrarlo, ascoltarlo, prenderlo in considerazione per quello che è a partire dalla sua storia clinica (si pensi ad anamnesi ed esame obiettivo così maltrattati!!). Questa posizione non è un optional ma ha un’innegabile utilità tecnico-professionale. Il Prof. Mahfoud nel 2010 ci ricordava che: “…la responsabilità emerge proprio da questa interazione, dalla presenza che uno è per l’altro in un incontro reale. Se manca la propria presa di posizione esistenziale, si amministrano processi, si coordinano riunioni, si esaminano dinamiche […]3ma, non si cura l’uomo reale.” Per tornare ai fatti di cronaca, occorre essere consapevoli che oggi la conoscenza si acquisisce insieme, nasce come competenza condivisa. Il lavoro d’équipe di cui tutti riconoscono la necessità non è per dividere, stemperandola, una responsabilità, ma per costruire umilmente percorsi nella complessità. Questi guidano, nelle situazioni specifiche, la responsabilità degli operatori che rimane drammaticamente dei singoli. Infine, come le indagini in corso sembrano suggerire, la responsabilità dell’operatore oggi non può non arrivare all’aspetto organizzativo, inteso come modo di lavorare al meglio; infatti se i professionisti non si assumono questo compito se lo assumeranno altri che non ne conoscono i termini reali. Offriamo questo contributo come spunto di riflessione e dialogo a tutti i nostri Colleghi desiderosi di collaborare al miglioramento dei luoghi della cura.
Paola Marenco
Gemma Migliaro
- M. Marzano, Disguidi, errori, criticità. La Repubblica 13 gennaio 2016.
- A. Pessina, Curare e prendersi cura, Leadership medica, 2002.
- Miguel Mahfoud, La dimensione della responsabilità nella motivazione dell’operatore e nella libertà del soggetto. Atti del Convegno “Il fattore umano”-Peschiera del Garda, 21-23 ottobre 2010.
SANITA’
- So cos’è la malattia, adesso mi batterò per cure più eque – (Corriere della Sera) Simona Ravizza – 11/01/2016
- Sangue infetto, nuova condanna all’Italia – (Il Sole 24 Ore) – 15/01/2016
PROFESSIONE
- Enpam, il fondo dei medici “guarito” dai derivati – (Affari&Finanza) – 18/01/2016
- Professionisti, welfare a 360° – (Italia Oggi) Simona D’Alessio – 18/01/2016
BIOETICA/BIOPOLITICA
- Aborto, una tragedia da non banalizzare – (Avvenire) Paolo Ferrario – 14/01/2016
- Maternità surrogata, toc toc femministe – (Il Foglio) – 15/01/2016